Caro Mastru, è il 24 dicembre di un anno in cui ci siamo accorti che siamo fragili e che umano non è una specie ma una promessa. Questo Natale, sarà per me segnato da questo racconto che Enrico Elefante ha lasciato qualche notte fa nella mia casella di posta. A poche ore dalla pubblicazione di questo video Enrico mi ha affidato questa testimonianza di vita. Dopo averglielo chiesto, abbiamo deciso, che forse, la cosa migliore era condividerla su queste pagine. Buona lettura.
Ciao, Jepis.
Ti scrivo da questa notte, da questa lunga attesa di Solstizio e di congiunture.
La passo in un posto e in un modo che è davvero come me, e me la sono immaginata, costruita e conquistata, questa notte.
È un po’ di tempo che non uso i social network, e già questo è stato qualcosa di molto significativo; mi hanno fatto notare della tua challenge, me ne hanno inviato il testo, e ne approfitto per scrivere, e per scriverti. L’ho preso come un segno, di qualcosa che forse andava proprio raccontato, e comunque andava almeno condiviso con qualcuno che potesse comprenderlo, e credo che il tuo spazio e la tua scienza possano esserne un innesco.
Sono in una attesa tangibile, di qualcosa che non è ancora ma che sembra proprio sia già.
Questa notte sibila che domani il giorno sarà un pezzetto più lungo di ieri, e ciò significa che anche se il freddo vero ancora non è arrivato, pare proprio che beh, la luce tornerà presto, e anzi addirittura che le giornate torneranno a dilatarsi e che l’estate vorrà proprio ritornare… ma non stanotte. Ora il tempo è di assenza del resto, di sospensione di giudizio sull’opportunità o meno del vivere o del morire.
Il pendolo stanotte è fermo, e io fremo con il mio tempo, immobile.
Sembra che tutto sia compiuto, e se una nuova era davvero non è arrivata ancora, allora non manca proprio nient’altro per far sì che si palesi; per lo meno nella mia vita.
Domani sera ci sarà il trigesimo della morte di mio padre. Cercherò di non soffermarmi su questo lutto oltre l’opportuno, dato che puoi immaginare quanto questa perdita abbia reso insignificante tutto il resto, per tutte le cose che faccio; e sarà logico trovarne traccia con riguardo ad ogni altra cosa ti scriverò, che non riguarda quell’evento ma che da esso ne è sicuramente toccato. Ti dirò solo che tra le cose, tra gli oggetti che mi ha lasciato ci sono il suo coltello e quello di suo padre, mio nonno, di cui porto il nome, come rinnovata eredità, come “memento vivere”. So bene che puoi immaginare la portata di questo gesto, di quegli oggetti e del significato che rivestono nella mia vita oltre il sentimentale e il sociologico.
Il resto riguarda la mia arte, anzi la mia bottega che è da dove ti scrivo, che guardando alla tua in qualche modo si ispira, e praticamente da sempre.
Quest’anno che sta per finire è cominciato l’anno scorso in questa stessa notte. Il solstizio l’ho quasi sempre vissuto con una grande intensità, non è un giorno come gli altri anche se è schiacciato da tutte le parti e dalle ricorrenze e le incombenze che cercano di metterlo da parte, di nasconderlo… un po’ come le antivigilie, che vivono il senso vero della festa pur essendone nemmeno l’ombra. Ho avuto modo di scriverne, altrove, e come le cose sensate che ho scritto me la ritrovo: ebbene questo giorno è per la vigilia di tutto il resto, e quest’anno è la sintesi di quanto è stato e che prepara ciò che sarà, qualunque cosa essa sia, per me.
L’ho preparata come l’hanno scorso, la veglia al fuoco di questa notte. Quanto è passato? Da quando il raccoglimento e l’isolamento non erano tanto scontati nella vita mia ed in quella di tutti;
da quando si usciva normalmente e la mascherina era una cosa da usarsi solo in rari e tristi casi, la piattaforma web di zoom la usavano -e la conoscevano- poche centinaia di persone.
Io ero nello stesso posto dove sono ora, una stanza pitturata una decina di anni fa con delle apine colorate, su uno sfondo giallo chiaro, che era la stanza da pranzo della casa dei miei nonni.
È il posto che mio padre mi aiutò a rendere più “mio” dandomi coraggio nel buttare giù un muro di separazione per farne un ambiente più ampio e accogliente di quella casa “vecchia” che era e lasciandomi fare grossi cambiamenti di stile e funzione pur dandomi l’idea di farlo ad ogni passo con qualche perplessità di fondo; come per tutte le scelte umane e professionali che abbia intrapreso e che non fossero di sua iniziativa, in fondo. Ma questo ha fatto parte del gioco delle parti tra me e lui, a cui mi ero praticamente abituato, più che rassegnato.
Questa che era la casa dei miei nonni paterni ora si chiama “la stanza delle api” proprio a causa di quelle apine dipinte, tutte intorno alle pareti. E ora mi sconvolge, seduto in questa stanza, collegarlo al fatto che la persona autrice di queste piccole opere d’arte dipinte con lo stencil una per una, tracciandone anche la scia con dei puntini neri e colorando degli esagoni sull’angolo del camino è la stessa persona che per una serie di congiunture ha prima accolto mio padre in ospedale, gli ha accordato le migliori cure possibili e lo ha persino anestetizzato, intubandolo, non prima di aver permesso a me, in testa al resto della mia famiglia, di poterlo salutare attraverso una video telefonata, in cui senza riuscire a parlare ha accolto la nostra improbabile sicurezza e la nostra vicinanza virtuale. E così si è ritrovata a fargli da Caronte, ed è l’unica persona testimone delle sue ultime parole e di tanta pena quanto conforto, tutte impregnate di ogni umanità possibile. Una eccellente professionista e appassionata mia conterranea che per quanto ne sappia vive in un solstizio costante, e che vorrei ricevesse da sé ciò che essa stessa accorda al suo prossimo. Ma ne parlo in questi termini anche offuscato dall’enorme peso che gli è stato destinato in groppa e che ha accolto senza esitare, curando mio padre nei suoi ultimi giorni di vita.

Le api ci stanno dipinte in questa stanza perché prima di partire sul serio a viaggiare in tre continenti e a raggiungere i migliori risultati del mio ambito professionale ho anche provato a dare un nome nuovo alla passione di famiglia ed a una piccola produzione di miele. Ci sono riuscito solo in parte, e senza troppa convinzione ho messo certificazioni, libri, idee ed energie apistiche da parte, scalzate dalla principale fonte di passione sul tema, incondizionata e totale: quella di mio padre.
Mio padre si è ritrovato Apicoltore per scommessa e rivalsa verso il suo, di padre, quel mio nonno che aveva cominciato a produrre miele con sua moglie praticamente come vezzo delle attività agricole che portava avanti naturalmente, ma non banalmente. Lo faceva dopo aver vissuto una vita già singolare, ed essere rientrato in Italia dopo essere stato prigioniero di guerra in Egitto, India, Australia. Avendo deciso di ricostruire una storia nuova, visse come il resto del suo mondo dei tempi di vera miseria dove qualunque cosa di dolce era più che sublime al palato, lo zucchero era un cibo fin troppo da signori, e il “nettare di sole” invece si otteneva con fatica e umiltà. Questa caratteristica rendeva l’apicoltura un’attività agli antipodi della boria caricaturale con cui tanti laureati all’università della terra si sono concessi il lusso inutile dei salotti, delle auto cromate, delle pellicce e di tante, troppe cianfrusaglie. E questo è stato emblema di quel benessere che stonava troppo con la storia di chi aveva fatto la prigionìa prima e la guerra poi.

Questa cosa strana delle api, difficile e pure un poco pericolosa, era un’attività che mio padre ha preso di petto probabilmente per provare al suo di padre oltre che a se stesso quanto fosse possibile fare bene un prodotto e curare un “sistema-animale” che è l’alveare, cambiandolo in un’opera d’arte che esige tanta sensibilità, oltre che l’abilità il tempismo e l’abnegazione che richiede ogni attività agricola.
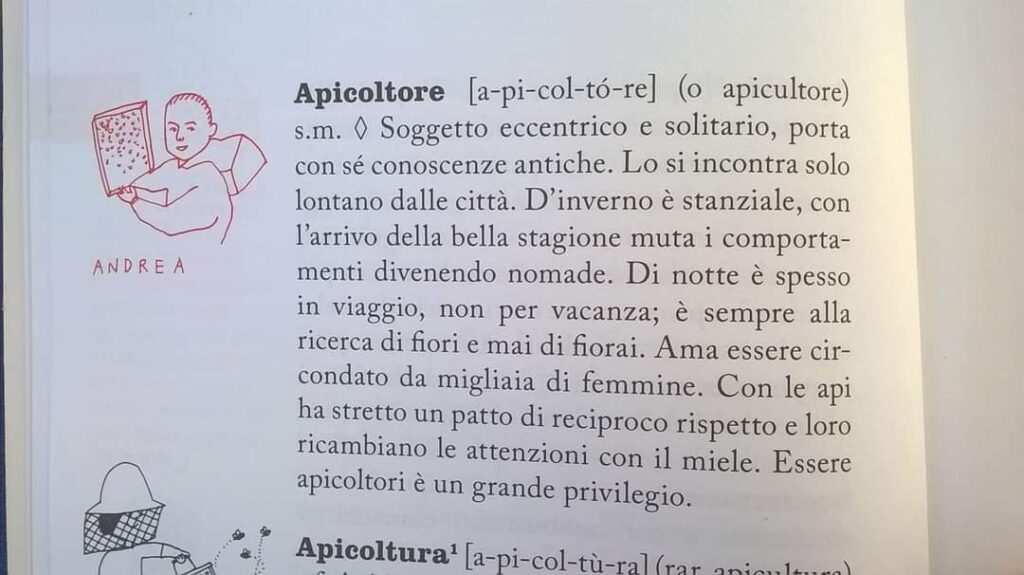
Questa è una cosa che ho imparato col senno di poi, praticamente. Di mio mi ci sono ritrovato da bambino, molte volte accanto a lui, ma raramente condividendo parole e gesti compatibili per un mestiere, quello di “leva e affumicatore”, che non permette digressioni, e allora ho a lungo solo subito una visione, un approccio che è quello che ha permesso ad un hobby di diventare molto di più, per lui e per tutta la famiglia.Il suo lavoro era un altro, i suoi mestieri sono stati tanti, le sue abilità innumerevoli. Nel suo stare con le api le metteva praticamente tutte in pratica, si metteva in gioco totalmente, lo sistematicizzava e lo connetteva col suo passato, con la molteplicità dei suoi talenti. E gli dava uno spazio praticamente tutto suo, in cui si beava di tanta grazia, in cui tentava di raggiungere obiettivi di qualità secondo i suoi canoni e di efficienza secondo la sua esperienza. E io, con il resto della famiglia, lo seguivo; però con una differenza sostanziale, dal resto della famiglia, in una cultura come quella di cui purtroppo o per fortuna sono degnissimo rappresentante: Io sono un uomo, e l’unico maschio di tre figli. E per giunta, l’ultimo.Senza avere il tempo o l’opportunità di svelarmene i segreti, senza poter chiedere o ottenere spiegazioni o strutturate lezioni al vero portatore dell’attività apistica di famiglia, questo solstizio mi trova ad aver invernato 50-60 alveari, che non sono molti per un’attività produttiva ma che sono tante per una piccola realtà familiare.
Nel glomere invernale le api sono in un numero tra le 10.000 e le 20.000 e vale a dire che approssimativamente in questo momento io sono responsabile e possessore di un patrimonio compreso tra le 50.000 e il 1.200.000 api, con una buona dose di scorte per l’inverno ed un buon trattamento autunnale, fatto già da mio padre come regola vuole, come ogni autunno, alla fine del raccolto.

E questo operoso letargo collettivo ad ora è il principale periscopio con cui osserverò l’allungarsi dei giorni, l’intensivarsi del freddo e l’intenerirsi dei germogli, prima del miracolo delle gemme e del delirio delle fioriture e quindi della sciamatura, che ahimè anche quest’anno seguirà con ogni
probabilità tempistiche assurde a causa dell’andamento delle stagioni e delle fioriture sempre meno prevedibili
Se l’anno scorso proprio in questa notte ho figurato il proposito del radicamento per me nella mia vita, non avrei mai potuto immaginare che sarebbe avvenuto in questo modo.
Questa stanza delle api è stato ed è ancora il mio studio, il mio laboratorio, la mia agorà ed è anche il posto del camino, che come l’anno scorso ho cominciato ad accendere solo in questa notte, per accenderlo l’ultima volta poi all’equinozio di primavera. Già, “Camino” proprio come la parola che in spagnolo indica il pellegrinaggio per eccellenza, sulla rotta delle stelle, d’altronde… ma questa è pur sempre un’altra storia, anche se mi riguarda da molto vicino.
Tornando a quello che vivo e a dove mi trovo… Non so come finirà e se questa storia continuerà così com’è, se questo luogo continuerà ad essere così.
Quest’anno mi è stata regalata una stufa a pellet, una vera comodità se non fosse per il fatto che per usarla dovrei rinunciare ad accendere il fuoco della legna, che di per sé è più scomodo e meno pratico, ma per questa volta, in extremis sono riuscito a ritagliarmi questo rito che in un anno mi ha fornito tanta verità al prezzo di tanta mestizia, ma anche una buona dose di risolutezza che cercavo davvero da molto, e che avevo cercato dappertutto.
E allora, più o meno come l’anno scorso, ho preparato una buona scorta di legna, ne ho tagliato a mano una parte da rami e ceppi secchi e ho acceso la prima fiamma alle luci del tramonto; continuerò ad alimentare il fuoco fino a quando riuscirò a vegliarvi. Alimentarlo e vegliarlo… praticamente a curarlo, quindi, come ci si prende cura di ogni cosa, come quel fuoco interiore che si prende cura di me e che mi accompagna dovunque vada, qualsiasi cosa faccia, qualunque forma prenda.
Al solstizio di Giugno conservai un legnetto contorto, un ricordo d’estate regalatomi dal mare di Paestum, che conservai proprio per questa ricorrenza, vergognosamente grato di quanto avevo già avuto nella prima clausura di primavera, che mi fece scoprire l’orto e bramare la montagna. Coerente ed ipocrita com’è ogni solstizio, anche quello d’estate mi dava certezze nella scoperta di un tepore che si sarebbe presto incendiato in una tempesta, che avrebbe accolto i miei 35 anni ad Agosto e mi avrebbe visto finalmente diventare uomo, con le mani nel fuoco che avevo come segno e nel cuore. Ma non lo sapevo ancora cosa voleva da me, quel fuoco che era solo nell’aria o da qualche parte di cui non avevo idea, che non conoscevo e che in fondo non mi importava conoscere; eppure lo avevo vegliato, ci avevo litigato, mi aveva fatto male e mi aveva salvato, accudito. Lo avevo offeso e vilipeso, molte volte. Mi aveva già chiamato e mi aveva abbracciato, mentre dormivo; e così, in estrema sintesi, l’ho ritrovato.
Stanotte l’ho acceso con un solo fiammifero e nessuno spreco, con la prima legna asciutta e pronta da mesi, e il resto con la carta dei fogli di calendario vecchi e conservati per essere bruciati, con la miseria di quelle promesse infrante, di quelle lettere che non saranno inviate, con quelle provocazioni a cui proprio questo fuoco mi invita a non rispondere. Insomma, con quel male che sempre lo stesso fuoco mi chiama a non lasciare marcire in rancore ma ad apprezzare per quello che è sciogliendolo in energia vitale, per guardare oltre, e dentro. Che in fondo è tutto parte integrante del mio essere umano e che voglio continuare ad addomesticare, nella perseveranza.
L’anno scorso piansi di meraviglia quando al mattino ritrovai la brace viva sotto alla cenere, una cosa che nei camini razionali non mi accade di trovare, ma in quelli rituali come questo mi lascia senza fiato dalla commozione, e mi collega a tutto quanto sotto la cenere delle meschinità di questo tempo e di questa umanità ancora si cela e che si trova molto vicino a quello che vivo, a quello che sono. L’anno scorso non avevo perso tutto, ma ora so che già non avevo niente. Adesso, stanotte, so
perfettamente di essere un privilegiato, nonostante tante privazioni e molte scelte dolorose, che non si sono ancora esaurite.
Ho la prerogativa di essere un formatore, una cosa che ho spesso rinnegato non riconoscendomi potestà di insegnamento nemmeno verso me stesso, e volgendo lo sguardo alla ricerca di maestri fuori di me senza sapere di avere interiormente molte più chiavi che serrature.
Mi sono ricordato delle conoscenze di etologia apistica, di gestione degli apiari e di quelle matrici di intimità che si sentono aprendo la soffitta dell’arnia quando ho trattato molti aspetti del mio lavoro nelle politiche giovanili, nella gestione dei gruppi, nel problem solving e nell’human empowerment. Nel mio lavoro tratto di approccio olistico alla formazione e quindi anche dell’importanza che riveste la corporeità e il rispetto di sé nella cura degli altri e addirittura del proprio mondo. Ciò che sembra avere conseguenze nulle o banali nella vita di tutti i giorni si ripercuote sistematicamente persino sui meccanismi delle istituzioni che governano i fondamenti del nostro vivere civile. Cose enormi, che partono da elementi molto semplici, banali, come la singola persona umana o una singola scelta; come non trovare parallelismi con la vita che c’è in natura, e specialmente tra i favi? Questo approccio valoriale di base mi ha fatto considerare come rivoluzionari quei concetti che principalmente nelle politiche giovanili e nell’educazione ai diritti umani di cui mi occupo sono ripetutamente e convintamente ribaditi come presupposti, ma che nella realtà dei fatti vengono ignorati o calpestati da interessi personali, miopie politiche e in definitiva da miserie umane.
Faccio evidentemente un lavoro che mi esalta umanamente e che mi appassiona profondamente, e per completarlo la sorpresa maggiore di quest’anno è che mi sto mettendo in gioco in tanti modi, riuscendo persino a ritrovarmi in uno dei ruoli che ho sempre ritenuto inopportuno e troppo inadatto alla mia indole tendenzialmente anticonformista: Sono educatore di Azione Cattolica proprio per i giovani della mia Parrocchia di origine. Questa novità mi da’ l’opportunità di rivolgermi a una, anzi tante versioni di me stesso di dieci, quindici anni fa; volgendo lo sguardo e la mano a chi può parlare con un sé stesso con qualche ruga in più ma con occhi davvero simili ai propri, affronto tra le ultime prove di quelle che quest’anno mi ha fatto trovare per strada.
L’anno scorso cominciai ad interrogarmi grazie ad una freccia, trovata in una foresta e che mi indicava con il nome “ambizione” la direzione del seguente solstizio di un anno fa, stanotte. E ora più continuo sulla strada del fuoco e meno sento lo scorrere del tempo ed il peso delle parole, che scivolano sempre più leggere, come il fumo esce dal comignolo.Ieri sono andato a mettere i piedi nell’acqua nel paese dove sono nato, 35 anni fa, e quella sensazione di freddo intenso, semplice eppur primordiale benché a suo modo traumatica, mi ha schiarito molti di questi concetti e mi ha fatto prendere molte scelte: domani non terrò nessun elogio funebre per mio padre; mi basta fin d’ora la commozione di potermi permettere tutte queste libertà, e di poter continuare ad osare di essere ciò che sono; e ce ne sarebbero tante altre che non vale la pena nemmeno ripescare dalla mente, e che mi basta lasciare a vegliare accanto a questo fuoco, aspettando l’alba che sicuramente farà la sua parte; grazie a noi tutti e malgrado noi, tutti.“Per dimenticare è necessario conoscere, Per rinnegare bisogna anche credere.”
Ti ringrazio per lo spazio che mi potrai riservare. Forse un giorno riuscirò a tirare i conti con le mie storie e queste righe proveranno ad essere la conclusione di un percorso lasciato in sospeso molto tempo fa, quando da solo mi ritrovai a guardare tremando negli occhi una divinità che mi sussurrò con un gesto quello che avrei dovuto fare nella prossima vita.
Ho vissuto finora molte vite singolari e in molti posti diversi; quello che mi resta davanti non è altro che il compimento di parole antiche e di una storia che in fondo mi porto solamente già scritta nel nome. Che si compone sulle mie gambe e cammina su queste parole, da me che le scrivo a te che le leggi.
Ciao, Jepis. Grazie per quello che fai, che è lavoro ben fatto.
Enrico.




